
VINI SPECIALI E ALTRE BEVANDE ALCOLICHE
Di vini, oltre a quelli che utilizziamo abitualmente a tavola, ve ne sono altri: e, in particolare, i vini liquorosi e i vini spumanti. Vini di cui è obbligo parlare, perché fanno ormai ampiamente parte dei consumi di bevande alcoliche.
E, dopo i vini, c’è la birra, ci sono le acqueviti, gli aperitivi a base alcolica, e così via. Il panorama delle bevande alcoliche è vastissimo, e vi sarebbe un’infinità di cose da dire: ci limiteremo quindi a parlare solo di quelle più schiettamente mediterranee.
I VINI LIQUOROSI
Table of Contents
Sono i cosiddetti “vini da dessert”, apprezzatissimi da alcuni, e per nulla apprezzati da altri, in prevalenza da coloro che, abituati a consumare vini “asciutti” da pasto, considerano i vini “dolci” poco meno di un’eresia.
Comunque sia, i celeberrimi Marsala, Porto, Madera, e così via, hanno schiere nutrite d’estimatori, che, ovviamente, non li consumano durante i pasti (anche se sarebbero preferibili alle coca-cola o alle aranciate con cui certuni pasteggiano), ma a fine pasto o fuori pasto.
Agli occhi del nutrizionista, hanno il vantaggio di non esser consumati che in modeste quantità, e quindi d’offrire i vantaggi, ma non i danni dell’alcool. La lavorazione dei vini liquorosi è alquanto complessa.
Anzitutto, occorre un vino di base, che deve esser prodotto esclusivamente con uve di particolari vitigni, riconosciuti dalla legge; la gradazione alcolica di questi vini non deve essere inferiore a 12° (pari a 96 grammi d’alcool per litro).
Tale vino viene successivamente “lavorato”, con l’aggiunta di sostanze zuccherine derivate esclusivamente da uva leggermente appassita (o anche da particolari uve fresche), di mosto concentrato, di alcool etilico purissimo (che può essere sostituito da acquavite di vino il cui grado alcolico non sia inferiore a 65°, pari a 520 grammi d’alcool per litro) e di “mistella” (detta anche “sifone”), cioè un mosto reso infermentescibile (ossia, incapace di fermentare) mediante l’aggiunta di alcool etilico o d’acquavite, in modo che la sua gradazione alcolica salga a non più di 22° (176 grammi d’alcool per litro), e a non meno di 16° (128 g d’alcool per litro).
A seconda della quantità di zucchero aggiunta e di altri particolari tecnici, si può ottenere un vino liquoroso “dolce” o un vino liquoroso “secco”. Un confronto tra la composizione di un vino comune (con gradazione alcolica pari a 11-11,1°, quindi già abbastanza “robusto”) e quella di un vino liquoroso “tout court”, di uno di tipo “secco” e della sua versione “dolce” può dare un’idea delle differenze esistenti tra tali vini (vedi tabella in basso).
COMPOSIZIONE DI ALCUNI VINI
| VINO | ACQUA | ZUCCHERI | ALCOOL CALORIE | |
| Comune | 89% | 0,3% | 8,9% | 64 |
| Marsala | 81% | 5 % | 14,4% | 120 |
| Porto secco | 77% | 4 % | 17 % | 134 |
| Porto dolce | 69% | 14 % | 15,5% | 161 |
I VINI SFUMANTI
Lo spumante si può fare con due diversi metodi: con il metodo cosiddetto “classico” (metodo champenois), il quale consiste in una fermentazione effettuata naturalmente in bottiglia, per la durata di diversi anni, e il metodo “Charmat” (dal nome dell’ingegnere francese inventore del metodo), che consiste invece nel far rapidamente fermentare i vini in grandi contenitori, prima d’essere imbottigliati.
II metodo champenois è nato anticamente nella regione dello Champagne (che, prima d’essere il nome di uno spumante, è quello di una regione della Francia), da cui deriva questo
termine; il vino destinato alla fermentazione champenoise deve derivare da una pressione molto morbida dell’uva, in modo che ne esca solo il”mosto fiore”.
Nella primavera successiva alla vendemmia, questo vino “adolescente” viene posto in bottiglia, e lasciato ulteriormente fermentare per alcuni anni (in genere, due o tre).
Per tutto questo periodo, lo spumante viene tenuto in posizione coricata, in modo che si formi sulla “pancia” della bottiglia un deposito, di grande importanza, perché è da questo che dipendono le caratteristiche d’aroma, sapore, fragranza (in una parola, il “bouquet”) di ciascun spumante.
Questo deposito, però, dev’essere eliminato: e l’eliminazione si ottiene con un’operazione complessa e delicatissima, detta “rémuage”. Le bottiglie vengono infilate per il collo nei fori di un apposito cavalletto, detto “pupitre”, in posizione orizzontale, avendo cura che il deposito resti nella parte inferiore.
Poi si procede a raddrizzare il “pupitre” (e quindi le bottiglie) con molta lentezza, facendolo ruotare di un ottavo di giro al giorno, finché le bottiglie non risultano perfettamente verticali, con il collo verso il basso. In questo modo, il deposito scivola lentamente, disponendosi in prossimità ed attorno al tappo: ed ora bisogna toglierlo.
Con una manovra denominata “dégorgement”, si congela una piccola parte dello spumante, quella vicina al tappo e che incorpora la feccia; poi si apre la bottiglia, e la parte ghiacciata viene espulsa. Si ritappa in modo definitivo, e lo spumante risulta limpidissimo. A dirlo, sembra molto facile, ma in realtà si tratta d’una manovra delicatissima, che esige una grande abilità.
Il metodo Charmat, invece, parte da un mosto, sempre ottenuto con una spremitura “leggera” dell’uva, su cui si opera con un sistema di vinificazione detto “in bianco”. Il mosto non fermentato viene introdotto in vasche refrigerate, dove lo si lascia decantare per effetto del freddo; poi lo si trasferisce in autoclavi (recipienti a temperatura e pressione controllate), dove lo si lascia fermentare in modo molto lento. In questo modo, si forma l’anidride carbonica che fornisce le caratteristiche “bollicine”.
Nel metodo Charmat, le sostanze aromatiche dell’uva di partenza vengono conservate intatte; ed infatti, mentre nello spumante metodo champenois il profumo deve essere delicato, ma intenso, privo però di “vinosità”, e la spuma bianca deve essere evanescente, con un “perlage” (o getto) continuo di bollicine a grana minutissima, nello spumante metodo Charmat si deve avvertire l’aroma dell’uva di partenza (per esempio, moscato), e la spuma ha minor consistenza, con un “perlage” meno intenso e bollicine fini, ma non finissime. Di vini spumanti ve ne sono di “brut” (extra-secchi), semi-secchi e dolci. Gli intenditori riservano il brut all’impiego fuori pasto, ed i semisecchi e i dolci ai desserts. In effetti, gli spumanti andrebbero utilizzati nel seguente modo:
- all’inizio del pasto, uno spumante brut, però fresco e giovane, servito a 5°-6° (non meno, per non perdere tutte le sfumature del bouquet);
- se si servono pesce, frutti di mare o piatti leggeri, si può utilizzare lo stesso spumante;
- se invece si servono piatti più consistenti (carni, selvaggina, ecc), è meglio utilizzare uno spumante brut più invecchiato, con un bouquet più ricco e più aromatico, da servire alla temperatura di 90-11°;
- con il dessert, uno spumante semi-secco, o addirittura dolce, da servire alla temperatura di 6°-8°, aprendo la bottiglia all’ultimo momento;
- fuori pasto, il tipo di spumante è indifferente. Il più indicato, sarebbe un brut recente, con un bouquet leggero, ma molti preferiscono uno Charmat dolce o semi-secco.
E molto importante ricordare due cose: la prima è che lo spumante dev’essere sempre conservato coricato, in modo che il liquido resti a contatto del tappo e ne garantisca la buona tenuta; e la seconda è che ogni bottiglia aperta deve essere consumata completamente.
Per chiudere questo argomento, occorre dire qualche parola sulle due grandi categorie in cui si dividono gli spumanti secchi: quelli “millesimati” (cioè, che riportano sulla bottiglia l’annata di vendemmia), e quelli privi di “millesimo”.
Ciò riguarda, però, solo gli “champagnes” francesi (in Italia, i vini analoghi, anche se perfettamente uguali, non possono esser chiamati così, essendo il termine “champagne” riservato agli spumanti francesi), perché non ci risulta che esista in Italia una legge che imponga di dichiarare la “annata” degli spumanti.
La legge francese prevede che si possano “millesimare” solo gli spumanti ottenuti in un’annata molto favorevole, e per non oltre l’80% del quantitativo globale prodotto. Di conseguenza, uno ‘champagne” millesimato è migliore, di solito più invecchiato, e possiede un corpo più robusto, un tenore alcolico più elevato e un bouquet più intenso.
Naturalmente, il fatto che la legge italiana non “imponga” il millesimo non significa che non vi siano produttori che non lo mettano sulle loro etichette: se poi si tratta di un socio dell’Istituto Spumante Classico Italiano metodo champenois, oltre ad esser garantita la veridicità del “millesimo”, l’invecchiamento minimo è di almeno 28 mesi dalla vendemmia, dei quali non meno di 18 di permanenza sulle fecce.
I nostri antenati mediterranei non disponevano di vini spumanti, così come oggi li intendiamo, ma disponevano dei vini frizzanti naturali, come il moscato; se non c’era il pronipote, insomma, c’era l’antenato: e tanto ci basta.
LA BIRRA
L’idea che Tutankamon (o Tuth-ank-amon, per chiamarlo correttamente), dopo un pubblico discorso, si rinfrescasse la faraonica ugola con un bicchiere di birra, può sembrare strana, ma è perfettamente attendibile.
Gli antichi Egiziani, infatti, producevano e consumavano birra: e anche se la birra centellinata dai costruttori di piramidi era probabilmente ben diversa da quella di oggi (anzi, probabilmente era una bevanda ignobile, che neanche il più scalcinato dei birrai oserebbe oggi propinare ai suoi clienti), gli ingredienti fondamentali – orzo e lievito – c’erano già. Quindi, bene o male, si trattava di birra: e sappiamo anche che producevano sia birra “bionda”, sia birra scura.
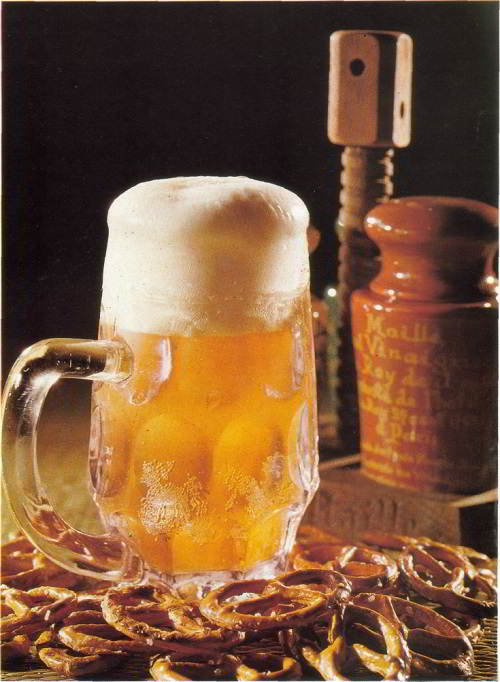
Quindi, sulla genuinità “mediterranea” della birra non vi sono dubbi. D’altra parte, la birra è legata alla coltura dell’orzo: e sappiamo che in antico l’orzo era largamente coltivato nel bacino mediterraneo, al punto che il pane più remoto veniva confezionato, appunto, con farina d’orzo. La birra, nel mondo antico, la conoscevano molto bene non solo gli egiziani, ma anche gli altri popoli mediterranei, e la tenevano in grande stima.
A dar retta a personaggi di non scarso rilievo, come Erodoto, Plinio e Diodoro Siculo, l’idea di ricavare una bevanda alcolica dall’orzo è attribuita niente di meno che al dio Osiride, e i Romani (dopo averla chiamata “vino di Pelusium”) la ribattezzarono “cervogia”, ossia “frutto di Cerere”.
La birra, in effetti, di nomi ne aveva molti: “zytum”, o “curmi”, come ricorda Dione Cassio (probabilmente, un termine utilizzato in Pannonia); “vìn d’orzo”, come la chiama Teofrasto (ed anche l’austero Tacito, quando, con aria di disapprovazione, dice appunto che i Germani erano soliti ubriacarsi con “vin d’orzo e di miglio”); “dezodos”, secondo il termine greco utilizzato anche da Aristotile, che ne parla diffusamente; e così via. Il termine “birra”, però, non lo si trova mai.
Il fatto è che i Romani, quando parlavano “scelto”, in buon latino, la birra la chiamavano “cervogia”; ma quando la ordinavano alla taverna, o ne parlavano in casa o tra amici, la definivano “biber”, ossia “bevanda”, per antonomasia. Col tempo, la seconda “b” cadde, e restò “bier” (come da “bibere” venne fuori “biere”, ed infine il nostro “bere”), che divenne poi “bir”, e infine “birra”.
L’entusiasmo per la birra non si spense con i secoli, tant’è vero che, superate le invasioni barbariche e la caduta dell’Impero Romano, lo ritroviamo intatto nel Medio Evo; nelI’VIll secolo, comparve persine, diffondendosi rapidamente, una canzone in onore della birra, scritta in lingua d’Oil, divenuta poi la lingua francese.
La birra, oggi, è il prodotto della fermentazione alcolica, ottenuta con ceppi selezionati di saccharomyces cerevisiae, di mosti preparati con malto d’orzo e acqua, aromatizzati con estratto di luppolo. Vi sono però anche birre (evidentemente, un po’ meno pregevoli) preparate partendo da malto di frumento, di riso o di altri cereali, aggiunto al malto d’orzo nella misura massima (per legge) del 25% del peso complessivo dei cereali impiegati.
Il colore della birra, variabile dal biondo pallido al rossastro e al bruno, è dovuto essenzialmente al colore dell’orzo utilizzato e alle modalità del suo essicamento. Se questo avviene a 60°, resta una elevata quantità d’umidità, che consente il verificarsi, tra zuccheri e aminoacidi, d’una particolare reazione (reazione di Maillard) che causa la formazione di melanine, con conseguente imbrunimento della birra stessa. La birra è una bevanda scarsamente alcolica.
Le birre “leggere” hanno un grado alcolico pari a 2-3°; le birre forti vanno da 4° a 6°; le birre inglesi “fortissime” hanno circa 8° alcolici. Quindi le birre leggere contengono 16-24 grammi d’alcool per litro; quelle forti, da 32 a 48 grammi d’alcool per litro; e quelle fortissime circa 64 grammi d’alcool, sempre per litro, cioè meno di un vino comune da pasto. Ciò significa che, per ubriacarsi di birra, occorre ingurgitarne quantità ragguardevolissime; ed è appunto ciò che accade, non tanto in Italia, quanto nei paesi dei “bevitori di birra”.
Il danno, allora, non è più provocato dalla birra, ma dalle enormi quantità di liquido introdotte nello stomaco, che, a volte, arrivano e superano i 10 litri al giorno; si manifesta, allora, il cosiddetto “cuore dei bevitori di birra”, riscontrato con una certa frequenza a Monaco di Baviera, dove, com’è noto, la birra scorre a fiumi, consistente in una dilatazione cardiaca (che esita in uno “sfiancamento” del cuore) dovuta alla imponente massa di liquido che questi è costretto a far circolare.
Comunque, l’ubriachezza dovuta alla birra ha caratteristiche del tutto diverse da quelle provocate dal vino in eccesso: invece di produrre un’eccitazione neuropsichica, produce torpore. Chi si ubriaca di birra (e ce ne vuole!), si addormenta pesantemente e non da fastidio a nessuno.
Oltre all’alcool, la birra contiene, ovviamente, acqua, una piccola quantità di proteine (circa 0,3-0,4 g %), pochi zuccheri (4% in media), discrete quantità di sostanze minerali (zolfo, fosforo e potassio, soprattutto) e vitamine del gruppo B, oltre a piccole quantità di destrine (derivati dell’amido), glicerìna, acidi organici, ecc. Il suo valore calorico, dovuto essenzialmente all’alcool, va da 29 a 34 calorie per 100 g per le birre leggere, da 40 a 51 per quelle forti, ed è circa 62 per le fortissime.
Per consumare “bene” la birra vi sono poche, semplici norme, che però è bene seguire:
- prima di consumarla, è bene lasciarla riposare almeno 3 ore;
- la si deve conservare sempre al riparo dalla luce, che ne danneggia la buona qualità;
- la si deve servire sempre con un’abbondante corona di spuma;
- deve essere conservata e servita a 4°-7: di temperatura, senza farla mai “gelare”, perché ciò rovina le caratteristiche della birra e danneggia la salute.
La birra, sia per il poco alcool che contiene sia per la presenza di anidride carbonica, stimola le secrezioni gastriche, ed è particolarmente indicata per accompagnare cibi grassi o di difficile digestione. È nota la sua capacità (però ma dimostrata scientificamente) di far aumentare la montata lattea (è utilizzata largamente a questo fine nella medicina popolare), ed è sicuramente un ottimo diuretico. Ciò che è meno noto è che la birra ha la proprietà di far eliminare l’acido lattico che si accumula nei muscoli sottoposti a fatica: e ciò può spiegare perché questa bevanda sia prediletta dai lavoratori manuali; e in particolare dai minatori.
LE ACQUEVITI
Le acqueviti (nome che deriva da “acqua di vita”) sono il risultato della distillazione di qualsiasi materia prima contenente alcool. Naturalmente, devono essere sane, genuine, in buono stato di conservazione, distillate in modo tale da eliminare ogni sapore sgradevole e conservare invece gli aromi del materiale da cui provengono, ed avere un grado alcolico non inferiore a 40° e non superiore a 80°. Di acqueviti ven’è un’infinità, nella tabella in basso citiamo però solo le più diffuse.
ALCUNE VARIETA’ DI ACQUEVITI
| ACQUEVITI | PRODOTTI DA CUI SONO DISTILLATE |
| Acquavite di vino | Vino di qualsiasi gradazione, con o senza le sue fecce naturali |
| Grappa | Vinacce (residui della spremitura dell’uva) |
| Rum | Mosto fermentato dalla canna da zucchero o le sue melasse |
| Whisky | Mosti fermentati e zuccherati di cereali |
| Acquaviti di frutta | Mosti fermentati del frutto corrispondente |
Che la distillazione sia un procedimento antichissimo, non v’è dubbio: veniva praticata già 3.500 anni prima di Cristo a Tepe Gaura, in Mesopotamia; il primo trattato alchimistico si fa risalire a Bolo di Mende d’Egitto, più noto con lo pseudonimo di Democrito (IV-Ill secolo a.C.); Plinio il Vecchio (attorno al 77 d.C.) parla diffusamente della distillazione (libro I, VII); Mariano Borgatti, nella sua “Enciclopedia minima” (1985), sostiene che la distillazione del vino era praticata fin dal 325 a.C.; e cosi via.
È Marcus Graecus che, attorno all’VIII secolo, fa per primo allusione a acquavite, chiamata “fuoco liquido”, e G.P. Porta, nel suo “De distilationibus” (Napoli 1609) afferma che il principio della distillazione fu perfezionato dagli arabi: e infatti, sia il termine “al-kuhl” alcool), dove “kuhl” significa “sostanza impalpabile”, sia il termine “alanbik” alambicco), dove “anbik” significa “recipiente”, sono arabi. Sull’origine mediterranea delle acqueviti, quindi, non ci pare possano esservi dubbi.

La distillazione, per la legge italiana, può essere frazionata o ripetuta, purché non si sorpassino gli 80°. Si devono eliminare le “teste”, ossia il primo liquido ottenuto, perché formate soprattutto da alcool metilico (fortemente tossico per i reni), anidride solforosa e altri componenti “indesiderabili, e le “code” (estratte per ultime) perché ricche di furfurolo, alcoli superiori, aldeidi ed eteri.
Resta così il ‘corpo”, ossia la parte nobile, ricca di alcool etilico e delle cosiddette ‘impurezze”, cioè dei principi aromatici del distillato, che conferiscono all’acquavite il suo caratteristico aroma, il suo bouquet particolare. .
Le acqueviti più diffuse nel nostro Paese, tra quelle più schiettamente mediterranee, sono il brandy (“brand”, in antico germanico, significava ‘fuoco”) e la grappa. Il brandy, distillato di vino, ha un grado alcolico pari a circa 44° (g 352 d’alcool per litro), ed è fortemente aromatico.
Per ottenerlo, il distillato di vino viene dapprima invecchiato per vari anni in botti e tini di rovere, dove si trasforma anche grazie alle sostanze cedute dal rovere e all’ossigenazione attraverso i pori del legno; poi viene sottoposto al “coupage”, ossia al taglio delle varie partite invecchiate, in modo da equilibrarne il bouquet.
Si noti che la parola “brandy” può essere usata solo se il prodotto ha subito almeno un anno d’invecchiamento: in caso contrario, si deve definirlo “acquavite, acquavite di vino, distillato di vino o arzente”.
La grappa, distillata dalle vinacce, ovvero dai residui della spremitura dell’uva, ha un grado alcolico leggermente superiore a quello del brandy (55°, pari a 440 g d’alcool per litro), ed ha un’aroma del tutto diverso, dato che manca delle sostanze aromatiche del vino, passate nel mosto con la spremitura. Le norme relative all’invecchiamento sono analoghe a quelle già esposte per il brandy.
Dal punto di vista calorico, il brandy sviluppa circa 250 calorie per 100 grammi, mentre la grappa è più calorica: 308-310 calorie.












